Esequie al design
Norma,
Si parla ancora di design. Purtroppo. Basta: le foreste gemono; e non ci è dato riscattare i fiumi d’inchiostro o i milioni di volt, versati al fine di giustificare il sostegno di vita artificiale a un accidente di percorso della storia dell’arte, a questo sgambetto storico teso dall’industria e da Gropius al regolare corso del prodursi artigiano (art-igiano: colui che frequenta le arti o abita le arti, al modo che il March-igiano abita le Marche. E forse non indegno di nota è il contrasto con l’art-ista, il tur-ista dell’arte che segue ma non frequenta, non abita l’arte, non paga l’affitto. Importante differenza fra quelli per cui c’è dell’–ano nella posta in gioco e chi segue guardando, presenzia alle fiere, borghese ben inurbato ma non ancora inumato).
Non si sprechi un’occasione di progresso: si dica sì all’eutanasia, alla “buona morte” del design che ci ha lasciati senza la possibilità di fare testamento biologico. Dunque un design ci sarebbe stato. Ma perché, e cosa sia stato, sono questioni ben lontane dall’essere state capite, o ancora solo avvertite, dalla massa progettante. È pacifico almeno che le formule del “problem-solving” e della “forma che segue la funzione” (o anche solo la necessità) siano ampiamente superate: ma lungi dall’esserlo per obsolescenza culturale, lo sono invece perché non è rimasto più nessun problema vero da risolvere. Nessun problema vero, cioè connaturato allo stesso design, che essendo morto non dà più problemi. Esistono ancora oggetti, s’intende, cose necessarie da progettare. Ma solo rarissimamente, per un ironico anacronismo, accade oggi che vengano progettate da un designer (art-ista e mai art-igiano). Dopo il post-modernismo resta il post-mortem. Il design, quello vero, è stato un’avventura a margine della storia europea, liquidato in sordina dall’ultimo spasmo epilettico del secolo ventesimo che ci lasciava prematuro, a tre quarti del suo corso, senza che un secolo nuovo potesse nascere (e bisogna tenere a mente che i calendari della cultura raramente arrivano in orario all’appuntamento numerico con l’inizio o la fine di un nuovo secolo).
Ora una piccola pausa, per aprire la finestra e fare uscire la puzza di nostalgia che i meno attenti potrebbero credere d’aver a questo punto avvertito. Facciamo arieggiare un attimo queste poche righe. Via ogni lezzo di conservazione. Non esiste un ventunesimo secolo, perché il ventesimo è morto accidentato lasciandoci, se non proprio vivi, almeno superstiti fra le lamiere e il vetro, come hanno sentito a varie svolte del Novecento tutti i teorici della “condizione post-storica” dell’uomo contemporaneo. E questo è un fatto dialettico, non una rimostranza morale. L’ultimo design autentico si è prodotto nel finale moto di ottimismo prima dell’ora estrema, nei tre decenni successivi alla fine della guerra, orientativamente fino alla metà degli anni ’70. Epoca di Fronzoni e di Munari, di Mari (che più acutamente di altri avvertì già la fine) e anche di Otl Aicher che negli ultimi scritti, sulla soglia degli anni ’90, vedeva lucidamente il futuro. Il futuro-presente, per i più acuti fra questi, era segnato dalla fine della cultura tecnica e civile che aveva investito il design delle origini e della maturità non già di un’indipendenza strutturale dall’arte (tarda illusione dei razionalisti) ma di un destino, di una missione culturale diversa da quella dell’arte pura. E Steiner: “Fare da ponte fra la cultura tecnica e l'umanesimo“.
Oggi, in Europa, il designer-servo della gleba inurbato (Milano, Londra, Berlino), prostituta del globalismo senza casa, senza patrimonio, senza privacy, 1 patetico soggetto imperiale anglo-americano, sfaccenda inconsapevole e obliato al canto della (crypto)moneta sonante (o suona almeno l’iPhone alla notifica del cambio valore: veloce, vendi). Quando avverte un disturbo al filo conduttore del senso, è un fastidio appena presagito, per istinto: manifesta la sua “disillusione” come può, o si rivolge malsicuro al discourse di settore, che prontamente lo incuba nella politichetta imperiale, erogata generosamente dai seggi pontifici delle accademie americane (domestiche o coloniali: Inghilterra, Olanda ecc.). In momenti di svago, invece, ci si dà al produrre meme passivo-aggressivi. Come osservato già in “Nulla di speciale”, Silvio Lorusso, che su questi temi ha pubblicato Entreprecariat (gratuitamente disponibile su Monoskop 2 ) e che attualmente ha in cantiere un secondo lavoro intitolato “Design and Disillusion”, oggi cataloga tutto ciò con una certa rassegnata diligenza.
Non si vedono uscite, perché la questione eccede e di molto, per portata, l’autonomia del designer. Al bazaar degli attivisti e di chi non fa più il designer (48: morto che parla) o non l’ha mai fatto e vive invece di consulenze, curatele, ciarle sulla design leadership e omelie, alieno al mondo della pratica, moniti come “designers need to take responsibility” si smerciano a gran profitto. Alcuni titoli recenti: “What Designers Can Learn from Indigenous Communities Fighting Climate Change”, “If We Want Design to Be a Tool for Liberation, We’ll Need More than Good Intentions” e molti altri sulla stessa traccia. Alice Rawsthorn, critica del design, ci informa col suo libro, rifacendo il verso a Helmut Schmid (il quale intendeva ben altro con il suo Gestaltung ist Haltung) che “design is an attitude“ e segnatamente, se si legge il libro per scoprire quale attitudine, è l’attitudine a confondere il design con l’attivismo politico. 3 Nell’escatologia di questi, se il designer non può essere il salvatore della società globale nel giorno del giudizio, dovrà almeno essere il whipping boy cui addossare la responsabilità di ogni falla interna alla società stessa, al sistema economico, a tutto ciò che sta fuori dalla portata della sua azione effettiva; e sarà bene che si mostri in pubblico soltanto munito di frustino per l’autoflagellazione.
Coscienza culturale e civile, ma di un design che edifichi. È questo che manca. Non si dà edilizia senza la certezza nel cosa stia a definire la ragione d’esistere di una categoria culturale, senza sapere perché si è necessari. Mai mera politica, con buona pace dei critici oranti, ma sempre e solo un fatto che derivi la propria necessità dall’intimo storico e umano. Con le sue proprie gambe camminerà poi per la polis, diventando anche politico, come ogni fatto significativo. E basti questo alla nostra orazione funebre.
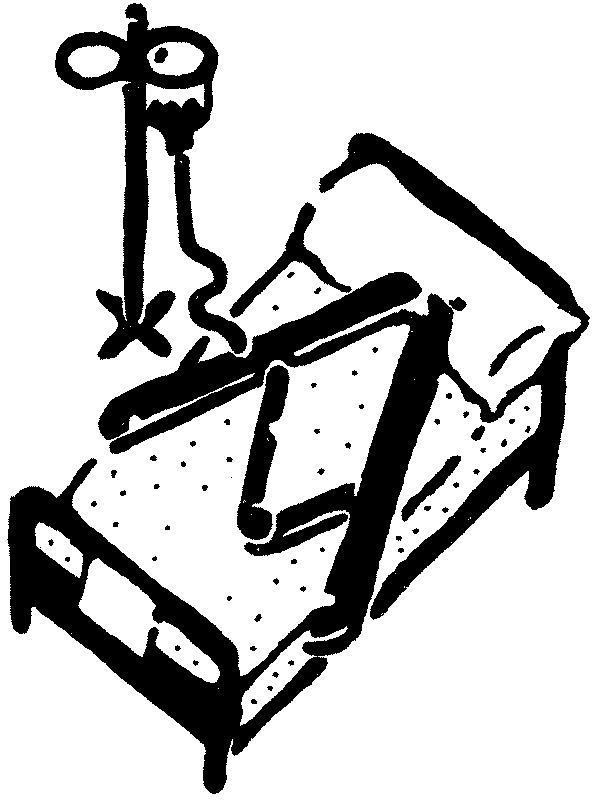
-
1
Secondo il WEF probabile realtà entro il 2030. (weforum.org)
↩︎ -
2
Silvio Lorusso: “Entreprecariat”. Krisis Publishing, 2018. (monoskop.org)
↩︎ -
3
Alice Rawsthorn: “Design as an Attitude”. JRP / Ringier, 2018.
↩︎